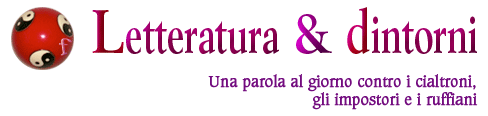Nota apocrifa del Bibliotecario di Gnomello
«La Formula dei Sette Nasoni, stando a quanto Infirmè De’ Pompetti ha letto nel libro intitolato Arte de lo Buffo et de le Beffe, di autore anonimo della fine dell’Ottocento, risale all’epoca in cui il gran maestro Bluphonarius scoprì (come riferisce l’anonimo), tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, il fenomeno proprio di un campo fino allora sconosciuto, che presto definì «Sacro Campo dei Bluphi, o Blufi o Bluffi o Blitei», cioè il fenomeno, quasi soprannaturale, della messinscena per visione o sogno.
I colori, indicanti i ranghi dei clown, seguivano (e seguono) la scala “dal bianco al nero”, secondo il criterio dell’intensità di tumefazione.
Un’opera di anonimo, dal titolo Bluphorum Ars Irrisionumque, sarebbe ora inclusa nell’Index incertus dell’Hominum hinstrionumque res gestæ e molto ben custodita come exemplar unicum in una ignota biblioteca o, forse, privata collezione della Provenza.
Indubbiamente l’Index incertus risulta introvabile, sebbene della sua esistenza sia prova una chiara annotazione che compare in fondo alla pagina xiv (ossia la pagina in cui sono registrati i riferimenti di biblioteconomia del tempo) dell’edizione in langue d’oc di uno scarno libretto dal titolo in latino, in cui ne è riportata la trascrizione. Il libretto, redatto a mano, rimanda all’anno 1692. Si tratta esattamente di un esemplare nel cui frontespizio si legge:
Libellus ambiguus
in Anno Domini MDCXCII datus
gentilium gaudium
nel quale si fa concisamente la storia di tale arte.
E in quel libro si può leggere ancora, caro monsieur Beauvais, delle strane interpretazioni del blufo, cioè di quel che si suole paragonare, in breve, con l’arte degli infingimenti e delle tracotanze dei saltimbanchi e giullari, e in qualche caso dei prestigiatori di strada.
Sulla vera natura e pratica di esso, non esiste alcun riferimento, però, né nei libri degli storici, né in quelli dei cabalisti o degli alchimisti, né in quelli della scienza. E neppure nei libri dei pagani, degli gnostici o delle sette segrete. E non si trova la benché minima traccia in alcuna bolla papale o della chiesa luterana o presbiteriana.
L’originale del Libellus risulta tutt’oggi catalogato al numero 279-septies (e perché septies lo sa solo il bibliotecario), scaffale ottavo, stanza decimanona, piano settimo, pars tertia ad dexteram (il cui ingresso è contraddistinto da un alto portone color ibisco e da una enorme lettera dell’alfabeto greco o cirillico: Ψ), edificio quarto, della Universalis Bibliotheca di Salisgrots.
Per gli acheogeografi, Salisgrots compare in una rara, forse unica Descriptio della Provincia Linguadoca del 1785, tra confini indistinti e altre città innominate.
Il libello è però molto diffuso nei luoghi d’arte e di cultura di tutto il mondo, benché, per vizio di scetticismo, sia poco consultato o letto. È risaputo, comunque, che i bibliotecari più attenti hanno voluto almeno una copia del volume, ad ornamento seppure di uno solo degli scaffali delle biblioteche da loro governate. E ciò avvenne dopo l’edizione prodotta (in una riuscita stampa anastatica) dalla casa parigina Bouillonclair di Jean-Pierre Bossetin, nel 1972, in tiratura limitata.
La Bouillonclair è andata in rovina nel 1989, anno della morte dell’editore, per cui il Libellus non fu mai ristampato.
La fotocopia della traduzione italiana del Libellus ad opera di Eliseo Bretonesi si trova pure nella biblioteca comunale di Sorrogne (al piano terra – l’unico –, stanza terza e ultima, proprio in fondo al corridoio, scaffale numero dodici ed ultimo, ripiano secondo ed ultimo, scomparto primo ed ultimo), una biblioteca immensa e assai ricca agli occhi del sindaco, essendovi custodite alcune altre anticaglie manoscritte catalogate a caso, data la facilità del loro reperimento.»