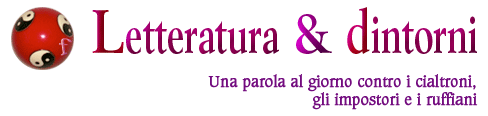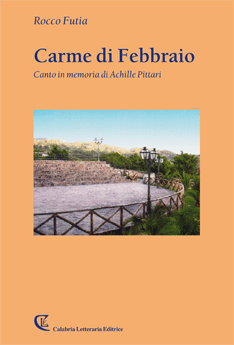«Il sacro vate,/ ...,/ i prenci argivi eternerà per quante/ abbraccia terre il gran padre Oceàno»: così scriveva Foscolo nel suo carme Dei Sepolcri. Se a questi versi uniamo, per continuità tematica ma anche per una stessa sensibilità poetica e percezione della morte, quelli del Bécquer della Rima LXXIII, «¡... hay algo/ que explicar no puedo,/ algo que repugna,/ aunque es fuerza hacerlo,/ a dejar tan tristes,/ tan solos, los muertos!», allora avremo uno dei significati del futiano Carme di Febbraio, nel quale l’andamento del canto rinuncia volutamente alla solennità preannunciata dal titolo per adeguarsi, invece, al ritmo “sussurrato”, quasi in sordina, suggerito dal ricordo e dal dolore per la perdita del «fiore che profuma» (Dopo l’inverno dei mortali, I).
Inoltre, se si considera il tema del Carme, non si può fare a meno di pensare che, proprio perché spesso assunto come topos letterario, l’autenticità dell’ispirazione avrebbe potuto essere stata inficiata da taluni “effettismi” che peraltro ritroviamo codificati e del tutto legittimati in buona parte della letteratura legata al planctus ealla lamentatio di derivazione classica. Facile sarebbe stato, infatti, per il poeta riproporre, magari in una cornice allegorica impreziosita da citazioni colte e riferimenti alla mitologia, e nei termini fissati dalla tradizione biblico-cristiana, il Vanitas vanitatum, per poi insistere sull’altro tema topico, il contemptus mundi o, seguendo una linea speculativa stoica, “confezionare” un lamento funebre che combinasse i toni del panegirico e della consolatio boeziana a quelli della letteratura gnomica. In un caso o nell’altro, il rischio sarebbe stato però quello di offrire al destinatario dell’opera solo e soltanto un prodotto estetico, godibile forse per l’inventio e la elocutio, ma il cui oggetto, il dolore per una morte prematura, si sarebbe ridotto a mero pretesto di scrittura. Perché questo non accadesse, perché protagonisti unici fossero sempre quel dolore e la pietas da questo generata, il poeta del Carme di Febbraio ha previamente rinunciato ad attingere al canone, che pure dimostra di conoscere, eha scelto di eclissarsi, di tornare ad essere soltanto uomo tra gli uomini per affidare l’animos impellere,così come ogni possibile esorcismo, non alla propria voce e abilità nell’organizzare la materia poetica, bensì alla nudità delle parole, «parole compagne» (Elogio del silenzio, IV) che, dunque, non appartengono più a lui ma a tutti coloro i quali, nonostante l’«avverso destino/ a cui soccombono anche i venerabili» (L’alba del ricordo, VI), continuano a vivere la «favola umana» (L’alba del ricordo, VI).
La rievocazione della «primavera verdeggiante/ dopo l’inverno dei mortali» (Dopo l’inverno dei mortali, I) smette d’essere perciò riuscita metafora per diventare invece accorato requiem, la «preghiera più giusta» (La sfida, V) recitata sottovoce dalla «madre del fiore rimasto in parte nel petto» (Elogio del silenzio, IV) e dal «vegliardo/ .../ esule/ dall’almanacco del tempo» (ivi). Annullato l’Io e la sua realtà immediata, l’unico universo contemplato nel carme è quello definito dai «luoghi del paese/ e degli amici», fatto poi coincidere col perimetro del dolore che, pur se infinito, è delimitato dal suo stesso oggetto, e dunque dal “Tu” d’apertura dell’ultima strofa di Dopo l’inverno dei mortali, che nella sua essenzialità, richiamata con forza dall’asindeto, riafferma un principio acronico e atopico di esistenza, simile a quello formulato da Salinas - «Existir en los pronombres» - nella Voz a ti debida. Quel pronome, quel “tu” che il poeta - più attento a farsi interprete di un dolore altrui, tanto assoluto quanto reale, che non all’esercizio retorico - libera da vincoli formali e dunque dalla dipendenza di un predicato verbale che ne determini l’esistenza in un tempo unico e non futuro, acquista un’intrinseca consistenza materica, un’essenza trascendente mai smentita dalla matericità oggettuale, dalla realtà delle «cose dintorno» (Cose tra le cose, VII) che, anzi, ne sono metonimicamente espressione. Sul piano cartesiano fissato nel Carme di Febbraio possono così coesistere, perché ricomposti in uno spazio di attiguità non oppositiva, il «campo dei morti» (La sfida, V) e quello dell’«orizzonte che si alza/ sopra di noi» (Il coro dei viandanti, III). Certo, in questi versi, come in altri, ritroviamo molto Novecento, un Novecento però mai esibito né ostentato, semplicemente rimeditato e proposto in una sintesi personale che combina, fra le molte possibili, le consapevolezze di un Pessoa a quelle dell’Aleixandre senile e poeticamente più maturo, diluendole al punto che queste costituiscono solo una leggerissima filigrana concettuale sulla quale si dispongono, fino a coprirla, le parole del dolore. Ripenso, per esempio, all’“aforisma” aleixandrino, «Qué difícil vivir. Un largo esfuerzo», e a quei lucidissimi versi del portoghese, «A morte é a curva da estrada,/ Morrer é só não ser visto»,(3) «Se escuto, eu te oiço a passada/ Existir como eu existo./ [...]. / Nunca ninguém se perdeu/ Tudo é verdade e caminho»(4) e ne ritrovo, volutamente sfumata, l’eco nella futiana visione dei due mondi che né «la Fata suprema/ vagabonda» (Ancora una parola, II), né «la notte/ ...potrà separare» (Elogio del silenzio, IV) o nel coro dei viandanti che «chiude il terrazzo dei sepolcri/ nella bruma di febbraio,/ dove inizia la salita/ e la fuga in un sogno/ che ci ricorda un uomo nel deserto» (Il coro dei viandanti, III). Eco, dicevo, perché voce e grido devono essere, per una chiara e mai tradita intenzione di scrittura, il pianto della «madre ... col cuore di colomba» (L’alba del ricordo, VI) e la pena del «vegliardo ... con occhi unti di brina» (Ancora una parola,II).
Mi chiedo se la scelta del carme, oltre che sottesi più facilmente individuabili, non nasconda anche, e forse prima di tutto, un desiderio, una pulsione vitale dell’uomo-poeta chiamato ad “eternare” un «volto amabile» (Dopo l’inverno dei mortali, I). E in effetti, se consideriamo l’accezione meno nota e desueta del termine “carme”, ossia quella di “scongiuro”, “formula magica”, “profezia”, allora sembra davvero probabile che l’intenzione ultima consegnata alla pagina sia quella di scongiurare la morte e l’altrui dolore attraverso la magia della parola, di garantire, a coloro che hanno visto l’amato fiore perdersi nello Stige, una catarsi, la consolazione di un miraggio, la profezia di un tempo di pace, la tregua e il beneficio di un’«ombra ristoratrice/ che intenerisce le gocce di rugiada» (La sfida, V) e rende la memoria, così come il tempo presente, più lieve, più tollerabile, più pura.
Anita Fabiani
Università di Catania
______________
(1) Carme di Febbraio, (Canto in memoria di Achille Pittari), Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli (CZ), 2003, pp.52.
(2) Il presente testo è apparso su «Scholae Praetoriatis», dicembre 2003, pp. 161-163.
(3) «La morte è la curva della strada,/ morire è solo non essere visto», Fernando Pessoa, Una sola moltitudine. A cura di Antonio Tabucchi, con la collaborazione di Maria José de Lancastre. Traduzione di Rita Desti, Maria José de Lancastre e Antonio Tabucchi, Adelphi, Milano 1987(2) , p.161.
(4) «Se ascolto, sento i tuoi passi/ esistere come io esisto./ [...] Ma nessuno s'è smarrito./ Tutto è verità e passaggio», ivi.