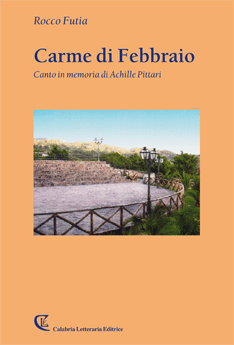Poiché ho già parlato delle liriche di Rocco Futia nell’introduzione al libro che oggi si presenta, non so se riuscirò ad evitare di ripetere qualche concetto espresso in quella sede. Tuttavia, voglio tentare di dare una lettura un po’ diversa: non nel senso interpretativo, ma cercando di focalizzare altri elementi che hanno richiamato la mia attenzione nelle successive letture di queste delicate liriche.
Le liriche sono doppiamente delicate: da una parte (tengo a sottolinearlo), per la limpidezza dello stile di Futia, in cui la perfetta sintassi associata a una adeguata scelta lessicale riesce a creare una musicalità particolare che fa da colonna sonora alle tenui (e al contempo vigorose) immagini verbali che scaturiscono dai versi; dall’altra, perché il tema trattato è particolarmente commovente, in quanto rievoca la scomparsa del giovane Achille, che quando pareva trovarsi nella fase ascendente della parabola della vita, viene sottratto ai suoi cari da un tragico e inaspettato destino.
Ma Achille non è richiamato in modo diretto. La sua presenza è evidenziata proprio dalla assenza.
Gli attori di queste liriche sono piuttosto i suoi cari, le persone della famiglia, coloro che gli sono sopravvissuti e che, straziati, continuano a tormentarsi con la sua immagine fissa nella mente perché non sparisca per sempre come il suo corpo.
Si intravede la figura della giovane sposa, ma si caratterizzano soprattutto le figure che lo hanno accompagnato fino all’età adulta: la madre, il padre, le sorelle. Tale presenza sembra voler sottolineare come l’infanzia non sia passata del tutto, come per i propri cari si rimanga fanciulli.
***
I venti versi della prima delle sette liriche che compongono il carme aprono con una localizzazione spaziale: “Retaggi quotidiani / e durevoli in cima alla torre della piazza”. La prospettiva dall’alto domina, come si vedrà anche in seguito, questa raccolta. È evidente che in qualche modo Futia, pur se di formazione laica, aderisce alla concezione cristiana del Cielo, alla verticalità del cammino dell’anima. Infatti, qualche verso più avanti propone ancora una focalizzazione elevata tramite l’uso del sostantivo “volo”: “il volo dell’aquila / che inclina / verso invisibili pinnacoli”.
E pure la speranza di un’altra vita è presente in questi versi d’apertura. La tramontana (intesa non come vento del nord, ma come luogo in cui avviene il tramonto: l’occaso, e dunque metaforicamente la fine della vita) non porta il buio della notte. Anzi, vi è proprio un richiamo alla luminosità, poiché il volo di quell’aquila scende precisamente “dai colli / splendenti a tramontana”.
E sempre la speranza affiora dai versi finali di questa prima lirica; la speranza di una primavera al di là di questo mondo in cui è inverno: “Tu, / nel cielo vermiglio della nuova aurora, / la primavera verdeggiante / dopo l’inverno dei mortali”.
* * *
Nella lirica successiva, che si compone di ventisette versi, l’apostrofe del poeta è sempre rivolta a chi non c’è più. A lui parla dei suoi cari, di coloro che sono rimasti in “questo inverno dei mortali” affranti dal dolore: la madre, con ancora nelle mani la sensazione della brezza tiepida del suo viso; il padre, che continua a tessere le lodi con la parola “forse vana forse no” (perché nel mitizzarlo lo fa sopravvivere ed egli stesso riesce a sopravvivere).
E anche in questa seconda lirica si può notare la speranza della vita che continua oltre la morte, quando si legge: “E la Fata suprema / vagabonda / nella voce d’una preghiera / appena smorzata / sul ponte che porta di là / fingendo la corsa nel campo dei gigli”.
Il verbo fingere, qui usato al gerundio, verosimilmente ha la funzione di mettere in evidenza come, nel mondo etereo della nuova vita, la mancanza del corpo può far solo fingere appunto le azioni.
Ho già detto in più occasioni come gli autori della letteratura spagnola ispirino – a volte, inconsciamente – Futia. Qui non posso fare a meno di ricordare la preoccupazione unamuniana per la sopravvivenza della sola anima.
Là, in quell’altro mondo,
mio cane, la tua anima
posare non potrà sopra il mio grembo
spirituale il capo spirtuale?
Povero amico, la lingua della tua anima
non lambirà la mano della mia?
(Miguel de Unamuno, Elegía a la muerte de un perro)
Per Futia, però, come si è visto, le azioni e la concretezza di questa vita pare che si riproporranno nell’altra, ancorché in forma spirituale. Quel “fingendo la corsa”, infatti, dà l’idea di una eterea danza in mezzo al campo di gigli, evidente simbolo di purezza e dunque del Paradiso.
Eppure, in contrasto con la gioia della corsa tra i gigli, vi è la figura del padre con il suo dolore dignitoso: non piange, ha soltanto gli “occhi unti di brina / e di tramonto”.
Dopodiché, una serie di isotopie relative all’effimero e al trascorrere della vita (polvere, sera, notte…) invitano alla visione un po’ più greve della morte.
* * *
Tanto è vero che nella terza elegia, che si compone di ventinove versi, ritroviamo una descrizione più angosciata, perché la distanza dalla tragedia è ridotta. È il momento concreto del distacco, l’accompagnamento del coro dei viandanti all’ultima dimora. Il primo verso è infatti composto da una sola parola: “Ora”: “Ora / il coro dei viandanti / chiude il terrazzo dei sepolcri…”. Questo nunc trafigge i presenti con la concretezza dell’avvenimento: la chiesa con il sarcofago e con il coro di prefiche, articolato come quello di una tragedia greca. Siamo “nella bruma di febbraio”, il mese più freddo dell’inverno e della morte. È vero che vi è la speranza perché “inizia la salita / e la fuga in un sogno”, tuttavia c’è anche il dolore e la penitenza. I versi, più precisamente, recitano: “… inizia la salita / e la fuga in un sogno / che ci ricorda / un uomo nel deserto / e l’orizzonte che si alza / sopra di noi”.
Con l’espressione “un uomo nel deserto”, Futia ci rimanda a Gesù e alla penitenza seguita dalle tentazioni, ma anche a Giovanni, a quella voce che grida “preparate le vie del Signore”, a colui che rimane sempre un passo dietro al Cristo. Dopo il deserto, però, dopo la sofferenza e le tentazioni, c’è sempre l’apertura alla speranza per quell’“orizzonte che si alza / sopra di noi”.
Ma per ora, in questo nunc del rito, pur “nel bagliore che circonda i celebranti” (bagliore che richiama una luce soprannaturale e paradisiaca), ciò che prevale sono le “stille”, vale a dire le lacrime, che vengono definite con una serie di aggettivi di grande effetto: sono “discrete”, perché non chiedono l’attenzione altrui; sono “segrete”, perché addirittura cercano di essere celate; sono “ignare”, perché non seguono più la realtà contingente; e infine sono “nude”, cioè senza riparo, “ mentre invadono l’ultimo cammino […] nella via della sera”, ovvero nella notte dell’anima.
* * *
La quarta lirica, di cinquantuno versi, si apre con un’immagine appartenente al campo semantico della luce, e dunque, ancora una volta, con il richiamo alla speranza.
“La fiaccola del nuovo giorno”, infatti, oscilla fra questa e l’altra vita (che ne è la naturale continuazione). Scaccia la notte e illumina la linea spartiacque tra la dimensione dei mortali e l’eternità, dando l’idea di tempo nullo che unisce i due mondi:
La fiaccola del nuovo giorno
si accende
oscillando tra due mondi
che la notte
non potrà separare.
E nella coscienza, nella chiarezza della effimerità e della brevità della vita, si rende alle cose un significato nuovo. O forse, semplicemente, si rende loro un significato: “Le parole del vespro / danno un altro senso alle cose”.
Tuttavia, pur nei continui richiami ai valori della speranza – si pensi a quell’“albore” (ancora una volta, un termine appartenente al campo semantico della luce) “albore / che la notte e il vento / non fanno vacillare” –, pur nei continui richiami ai valori della speranza, dicevo, il padre continua con passo fermo e dignitoso, nel suo inimmaginabile dolore. E la madre, nella sua “mestizia celestiale”, non può soffocare le lacrime per quel “fiore rimasto in parte nel petto”. La dolcezza con cui è dipinta la figura materna, poi, richiama in un certo modo la madre del Cristo affranta sotto la Croce. Infatti, anche nell’immagine che ci dà Futia troviamo una donna addolorata che ha “fermo lo sguardo / all’orizzonte dei suoi occhi, / con il solo velo d’amore / datole in sorte”.
Mi pare interessante rilevare ancora, a proposito di questa lirica, come negli ultimi versi il poeta faccia una netta distinzione tra le parole “effimere” e le parole “compagne”. Le prime sono quelle vane e fragili, quelle doverose che arrivano da chi il dolore non può percepirlo come proprio; sono le parole dei condolenti di maniera. Le parole compagne, invece, sono quelle che vengono recuperate nella mente dei cari: quelle dell’affettuoso scherno (di un tempo non lontano) tra fratelli; quelle dell’affetto coniugale… Esse sono:
come ieri
un po’ tempo
un po’ scherno fraterno
un po’ gioco d’affetti
un po’ dolceamaro rimando
a proverbi familiari
e a notti che raccontano l’amore.
* * *
Nei cinquantadue versi della lirica successiva, colpisce il titolo: la sfida. È un titolo che pare esulare dal contenuto e dal tono mesto finora seguiti. Sappiamo che, per statuto, la titolazione ha – tra le altre funzioni paratestuali – anche quella di designare il contesto che rappresenta. Tale titolo, dunque, parrebbe rivelare che il tema soggiacente in questi versi è quello della lotta contro le avversità. E tuttavia, il sostantivo “sfida” risalta per il contrasto. La sfida, infatti, è “esile”, difficile dunque da vincere. Comunque serve per avvicinare i cari nella solidarietà:
L’esile sfida
avvicina l’uno all’altro
nel quasi silenzio della notte…
Di grande suggestione è l’opposizione tra il “quasi silenzio della notte” e le “valli amene” con “ruscelli gorgheggianti” di qualche verso dopo. Il “quasi silenzio della notte” da enunciato che sollecita due sensi (l’uditivo e il visivo: silenzio, notte) passa a proporsi come locuzione temporale, vale a dire come momento dell’enunciazione a partire dal quale si riscatta nella mente il tempo della non coscienza della morte. Per chiarire meglio: nel “quasi silenzio” è “quando gli sguardi / percorrono pianure di sole / […] / e valli amene […] e ruscelli gorgheggianti / dopo il disgelo”. È evidente che l’evocazione parte da una “notte” di febbraio per ripercorrere i momenti di una primavera (dopo il disgelo); parte cioè da un presente per portarsi analetticamente a quando si poteva ancora gioire di una presenza. Al contempo, però, la locuzione appena citata funziona anche come tempo dell’enunciazione prolettica. È sempre a partire da quel momento, infatti, che ci si proietta al “ricordo di domani”; perché dal momento in cui si filmano immagini da riscattare nel futuro, abbiamo “nel quasi silenzio della notte” la certezza che “vivremo il domani / con gli occhi puntati sul ricordo”.
Vi è in questa lirica una serie di metafore di grande effetto sul valore della preghiera intesa anche come poesia:
La memoria
ci farà dono della preghiera più giusta
e nostro mantello
sarà la fiaccola di Parnaso
da cui sgorga un’ombra ristoratrice
che intenerisce le gocce di rugiada
posate dalla notte nel campo dei morti…
“La fiaccola di Parnaso”, dunque (cioè la poesia), se da una parte commuove (“intenerisce le gocce di rugiada”), dall’altra diventa “nostro mantello”; vale a dire, un elemento di protezione che aiuta a mitigare il dolore della perdita.
Molte altre metafore si incontrano ancora in questi versi, come per esempio quella che richiama il frustrato desiderio di crescita di una “rondine intrepida / che agognava il volo dell’aquila”. E il termine “rondine” non serve solo come misura di comparazione con la grandezza mai raggiunta dell’aquila: con questo lemma si vuole richiamare anche il motivo del ritorno. Così come le rondini ritornano a primavera, allo stesso modo “Quella rondine / torna alla primavera d’ogni giorno / sulle ceneri consacrate / ai silenzi del vespro incolmabile…”. Vale a dire che il ricordo sarà quotidiano e perenne nelle quattro persone a lui più care: il padre (il vegliardo) e le quattro donne (la moglie, la madre e le due sorelle).
Ma, negli ultimi due versi, Futia pare affacciarsi ancora verso una concezione cristiana del senso della vita:
Quella rondine
ha percorso la primavera
di un sogno
apparentemente mancato
o di una sorte segnata anzitempo.
In quell’“apparentemente mancato” notiamo infatti l’invito a preoccuparci delle cose essenziali. Mancato è il sogno terreno, quello che in fondo è vano; ecco perché troviamo l’avverbio “apparentemente”, grazie al quale si capisce anche che invece il sogno reale (l’aspirazione massima del raggiungimento della vera vita) è conquistato.
* * *
Nella penultima lirica, composta da trentotto versi, colpisce l’assillante figura dell’apostrofe, che ora è rivolta verso il padre:
E tu, vegliardo,
parli di lui…
Tu,
gagliardo in un anfiteatro di apoteosi
e di vanto…
Tu,
col nome più amato sulle labbra…
E, anche quando viene richiamata la figura della madre, il vegliardo – come lo definisce Futia – è sempre presente:
Tu e la madre
che piange col cuore di colomba…
Ma benché per una volta la figura del padre sia accompagnata da quella della madre, in realtà l’insistente apostrofe (l’incessante “tu”, “tu”…) serve a sottolineare la solitudine incolmabile dell’uomo. Ciò è evidente soprattutto negli ultimi versi della lirica, che recitano:
Tu,
con le gemme nel petto,
roccaforte e santuario nella nebbia,
solo
con il tuo urlo segreto,
col volto in cui si placa l’inganno.
Quel “tu”, dunque, si associa al terzultimo verso, che – per stagliarsi meglio sulla pagina in modo da risultare più incisivo – è composto da un’unica parola: “solo”. Tu, solo!
Forse è il caso di fare un veloce accenno alla forza che sostiene il padre, quel vegliardo che si mantiene “impavido nelle acque dello Stige [il fiume della paura] / a rammemorare virtù”. Prevale ancora, dunque, l’ansia di lodare riscontrata nella seconda lirica; ma questa volta pare che l’elogio avvenga nel silenzio del proprio animo: il padre con le gemme nel petto (vale a dire con l’orgoglio delle cose belle attribuite al figlio, con il vanto) è “roccaforte e santuario”. E, con il raccoglimento dovuto nei santuari, tace ed accetta la sorte: il suo urlo è, infatti, “segreto”; e “l’inganno” (ovvero l’illusione dell’effimero che ha sognato per il figlio) si placa.
* * *
La settima ed ultima lirica è la più breve fra quelle che compongono l’opera. Infatti, consta di soli diciannove versi.
Anche questo componimento inizia con un “ora” (così come si è visto nel III, intitolato “Il coro dei viandanti”); tuttavia, in questo settimo gruppo di versi, c’è uno scarto temporale. Il nunc che qui ritroviamo è quello del giorno dopo, ma non si tratta di una prolessi, vale a dire di un’anticipazione di ciò che succederà: c’è piuttosto uno scorrimento in avanti del tempo dell’evocazione, come se il poeta avesse seguito annotando giorno per giorno gli avvenimenti, e si ritrovasse adesso, nel giorno successivo, ad illustrare il momento della casa vuota.
Il giorno nuovo sorge; tutto pare essere rimasto immutato: le cose riposano tra le cose, come sempre. Nulla parrebbe essere cambiato in quel contesto che – come ho già detto nell’introduzione al Carme… – richiama l’“Elegia” corazziniana. Eppure, anche se tutto sembra uguale, la casa è pervasa da un particolare raccoglimento, dove “il sussurro delle ancelle / rompe appena la quiete”. Nel silenzio quasi religioso, pare di sentire dei passi:
E i passi
si posano nel silenzio,
sopra di noi.
Ecco di nuovo, in chiusura, quella localizzazione dall’alto con cui esordiva la prima lirica. Ancora una volta, dunque, Futia apre alla speranza di una vita celestiale che fa seguito alla morte fisica. È vero che il tempo scorre scandendo le ore che non sono più recuperabili (e tutto ciò è simboleggiato dal fluire delle tre fontane della piazza):
…il gorgheggio
di tre fontane
che accompagna la notte
nel suo arcano cammino,
tranne il tremolio della lanterna
appesa sul quadrivio.
Ma voglio anche credere che il tremolio della lanterna appesa sul quadrivio non sia soltanto metafora dell’indecisione (per l’oscillazione della fiamma); non si riferisca all’incertezza nello scegliere tra la pluralità di strade da intraprendere per superare il dolore. Forse – o almeno così mi piace credere – Futia ha voluto dare un’altra simbologia: la fiamma sfavilla e illumina tutte le direzioni affinché gli uomini sappiano scegliere la via migliore, la Via della luce e della speranza, quella Via di verità e di vita che permette a chi l’imbocca di non morire in eterno.
San Giovanni di Gerace, 18 maggio 2005
Domenico Antonio Cusato
Università di Catania